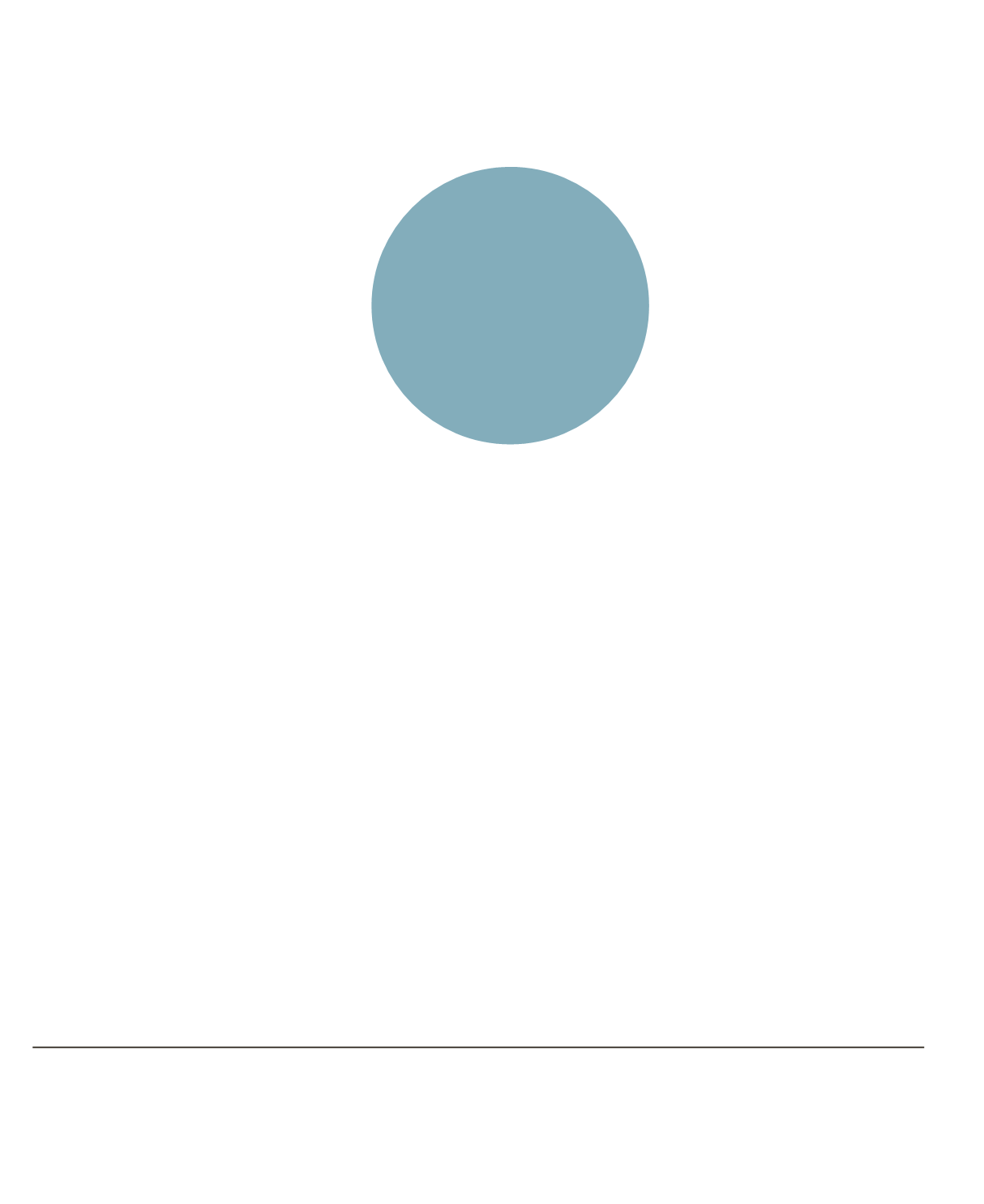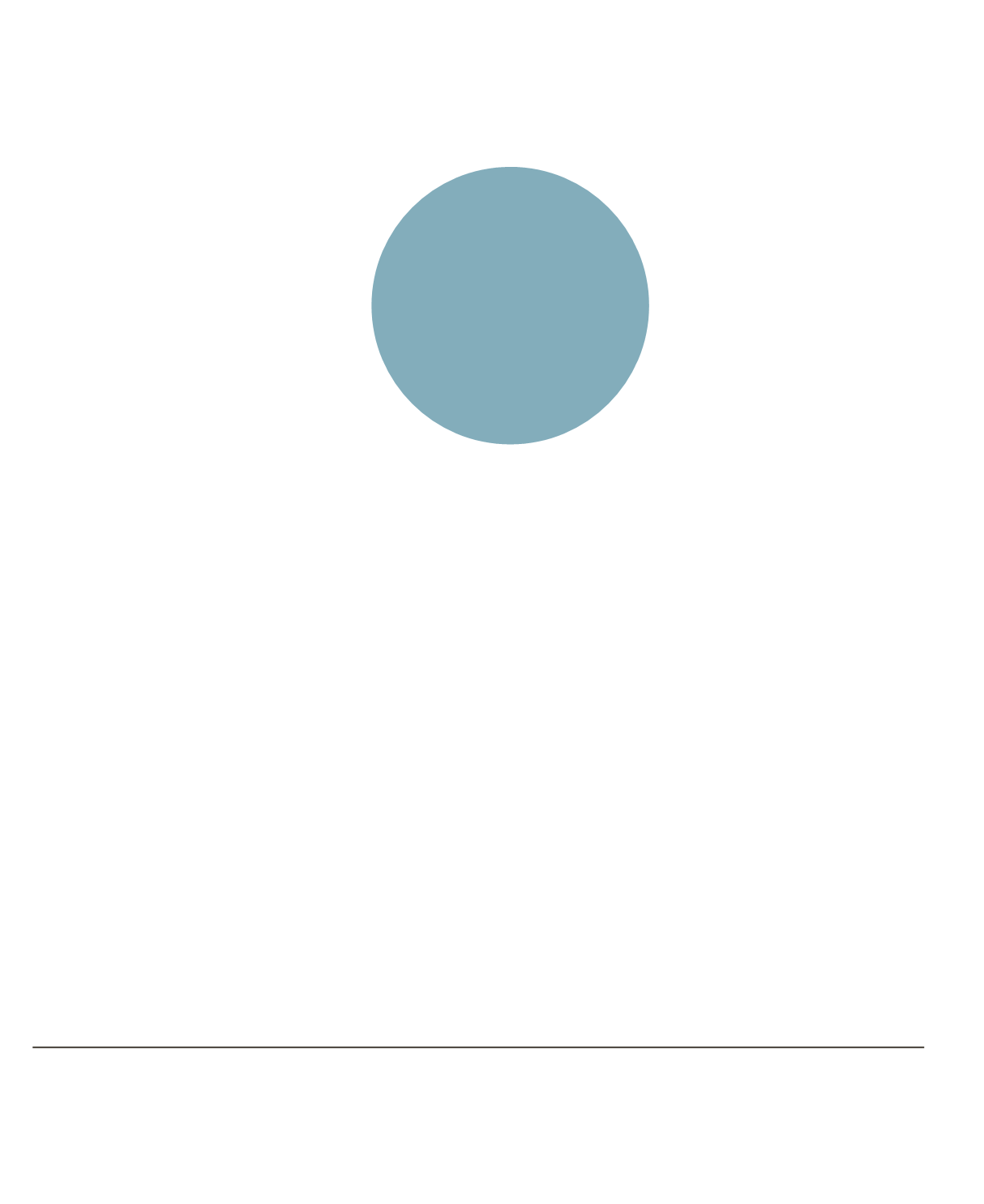
strategie
Roberto Camagni
Ordinario di Economia Urbana
e di Valutazione economica
delle Trasformazioni Urbane
Politecnico di Milano
Le aree metropolitane italiane
L’
idea della necessità di dotare le grandi aree metropolitane
di istituzioni sovra comunali che possano innovare nei loro
sistemi di governo e nelle loro pratiche di governance non è
nuova. Essa nasce storicamente da molteplici esigenze ritenute cruciali
nell’attuale fase complessa di crescita fisica ed economica di questi
territori, gravida di rischi per la sostenibilità e per la competitività dei
territori stessi. Da un lato, la centralità delle aree metropolitane nei
processi di internazionalizzazione e di globalizzazione è apparsa chiara,
almeno in Europa, da quando il Presidente Jacques Delors annunciò
il progetto di Grande Mercato Unico Europeo nel 1985, cui seguì un
prolungato periodo di intensissimi investimenti da parte delle grandi
imprese multinazionali – industriali, finanziarie e commerciali – nelle
aree di punta dell’economia dei singoli paesi, i ‘gateways’ della loro
internazionalizzazione: le grandi città metropolitane appunto.
Il processo terminò nel 1992, anno dell’approvazione del progetto di
Mercato Unico, a riprova della strategicità degli annunci (affidabili)
prima che delle vere e proprie realizzazioni
(1)
, ma si ripropose in
seguito con caratteristiche assai più selettive: alcune città proseguirono
la loro crescita e la loro attrattività, mentre altre – e fra queste le
grandi città italiane – restarono sostanzialmente ferme e furono
superate da città europee anche di minore taglia e minore storia
(2)
.
Ma d’altro lato gli intensi processi cumulativi che si mettono in moto
allorché la potenza economica e politica delle grandi città si sposa
con le decisioni sulle nuove grandi reti di trasporto e comunicazione
e con gli elementi simbolici della ‘centralità’
(3)
, non possono non
generare tensioni territoriali, trasformazioni spesso disordinate,
crescite insediative che sfidano la capacità dei sistemi di pianificazione
di mantenere un ordinato ed equilibrato sistema territoriale. Si ha
l’impressione che tali sistemi di pianificazione, spesso frammentati,
non siano in grado di tenere il ritmo delle trasformazioni e della
crescita quantitativa delle grandi città metropolitane
(4)
. Milano, con
un sistema di governo urbano per 1,3 milioni di abitanti, costituisce
il polo di riferimento funzionale – ma non il centro ‘ordinatore’ – di
un’area di 4 milioni almeno di abitanti (o di 6 milioni come indicano
alcuni studi internazionali), un’area fin qui affidata alle cure di un
ente istituzionalmente debole come la Provincia. Un controsenso e un
chiaro vuoto istituzionale. Le sfide per il nostro paese – ma anche per
tutti gli altri - sono dunque oggi sostanzialmente due, che presentano
un’urgenza forte amplificata dalla crisi: una sfida economica e una
sfida territoriale e di pianificazione. E non vi è chi non veda che le due
si intrecciano fortemente, perché un territorio efficiente e di qualità
costituisce elemento di attrattività e di competitività e perché solo una
visione di sviluppo che riesca a coinvolgere tutto il capitale produttivo,
cognitivo e innovativo presente sull’area vasta può essere capace di
rilanciare le nostre grandi città. Si pone dunque oggi l’esigenza di
superare egoismi municipalistici, la storica frammentazione territoriale
e la tradizionale modestia decisionale in ambito territoriale nonché
la necessità di raggiungere una massa critica sufficiente di risorse:
territoriali, produttive, umane, di ricerca e di creatività. La parte del
disegno di legge Delrio che tratta della città metropolitana, approvata
dalla Camera e oggi in discussione al Senato, è certamente la più
fragile, anche perché sconta un insufficiente contributo di riflessioni
da parte della cultura territoriale e un insufficiente dibattito politico
sul tema. Certamente questa parte è quella in cui la distanza fra
obiettivi e soluzioni appare tale da far presagire un’ennesima occasione
mancata per il paese. Servirebbe infatti, come recita la relazione al
disegno di legge iniziale, “uno strumento di governo flessibile, dalle
ampie e robuste competenze, in grado di essere motore di sviluppo e di
inserire le aree più produttive nella grande rete delle città del mondo”:
dunque una istituzione davvero forte, cui delegare dal livello comunale
Note:
1 Si veda: Camagni, 1992; Camagni e Gibelli, 1996.
2 Si veda la Presentazione
di chi scrive all’Osservatorio sulla Qualità
della vita a Milano, Megliomilano, Milano, 2010, 2011
e 2012, in cui si documenta lo scivolamento di Milano
e ancor più di Roma nella gerarchia urbana europea.
3 Si vedano ad esempio le decisioni sulla creazione
della grande rete di trasporti ad alta velocità che collegò le
grandi capitali del nord-Europa in quegli anni (’80 e ’90).
4 Si veda: Camagni, 2001.